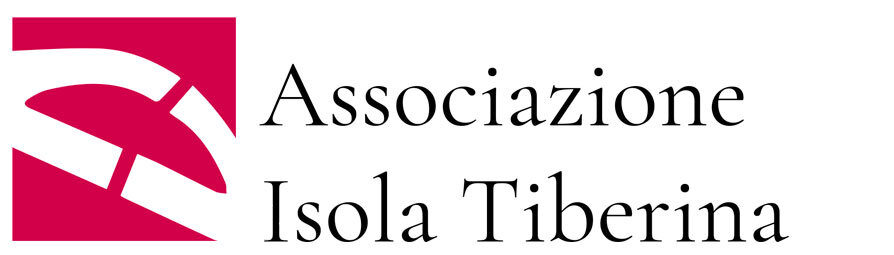L'isola come rifugio dell'uomo
-

L'ospedale Fatebenefratelli
LE ORIGINI
Verso il 1491 vicino ad Èvora in Portogallo nacque Joâo Cidade, oggi venerato come San Giovanni di Dio dal nome che assunse come consacrato (fig.A1). Dopo una vita avventurosa si dedicò all’assistenza dei malati e fondò a Granada nel 1539, con lo scopo di assistere i malati e i poveri, una famiglia religiosa di “Frati Ospedalieri”. Questo nuovo Istituto Religioso fu riconosciuto nel 1572 da Pio V con la Bolla "Licet ex debito" e prese in Italia il soprannome di “Fatebenefratelli”, dalla frase con cui il santo invitava i passanti a fare la carità: «fate bene, fratelli, per amore di Dio». Papa Sisto V con il Breve "Etsi pro debito" elevò la congregazione ad Ordine Regolare nel 1586 riunendo le comunità diffuse in varie nazioni sotto un unico superiore residente a Roma nell'Isola Tiberina.
S. Giovanni di Dio morì nel 1550 a Granada e non venne mai a Roma, ma i Fatebenefratelli vi giunsero, per la prima volta nel 1572, e qui fondarono nel 1581 il primo nucleo ospedaliero nella ex “casa degli Orfanelli” in Piazza di Pietra (fig.A2), il cosiddetto “Ospedale nuovo” di soli 20 letti. Nel giugno 1585 si trasferirono all’Isola Tiberina dove, con l'aiuto del papa Gregorio XIII, avevano acquistato un monastero, già occupato dalle monache benedettine (le Santucce) fino al 1573 e successivamente dalla Confraternita dei Bolognesi. Il pontefice concesse inoltre loro la contigua chiesa di S.Giovanni Calibita.LA STORIA
Tra la fine del ‘400 e gli inizi del ‘500 avvenne la trasformazione degli ospedali da ospizi, semplici ricoveri, a luoghi di cura, dove si cercava di guarire il malato e restituirlo alla vita normale; comparvero figure quali i “phisici”, cioè i medici che si occupavano di stabilire le cause e i rimedi della malattia, e i “chirurgi” che operavano fisicamente sui malati. In questa evoluzione ospedaliera si inserì e si espanse il Fatebenefratelli.
L’ospedale si ingrandì gradatamente acquistando e affittando alcune casette circostanti abitate da conciatori e pescatori. Allo scopo di acquisire spazio la stessa chiesa di S.Giovanni Calibita fu ridotta da tre navate, ancora visibili nella pianta del Bufalini del 1551 (fig.B1), all'attuale unica navata: in particolare la navata sinistra divenne il corridoio di accesso al complesso.
Nel 1656, durante la gravissima pestilenza che colpì Roma, si stabilì di riservare l’ospedale agli ammalati di peste sfruttando il naturale isolamento garantito dall’isola stessa: il 18 giugno l’intera isola fu sgomberata e adibita a lazzaretto per gli appestati (fig.B2). I Fatebenefratelli non addetti ad assistere i malati si trasferirono a S.Maria della Sanità, al Viminale, e i Francescani di S.Bartolomeo al convento dell’Aracoeli; gli altri abitanti dell'isola furono sfrattati e compensati con un modesto risarcimento. Sui due ponti di accesso all'isola furono installati doppi cancelli, come visibile nella pianta in fig.B3 derivata dal Codice Chigi. L’ospedale fu destinato al ricovero degli uomini e la torre dei Caetani e le case vicine alle donne. Il 18 ottobre un'ordinanza decretava la fine dell’emergenza e consentiva ai proprietari di rientrare nelle proprie abitazioni sull’isola.
In fig.B4 è la situazione dell'ospedale come appariva nel 1676 nella pianta di Roma del Falda.
Nel 1700 l’ospedale fu ristrutturato dal Carapecchia: in tale occasione fu completata la risistemazione della Sala Assunta, prima moderna corsia ospedaliera con 50 posti letto (v. sez.C); nella pianta del Nolli del 1748 in fig.B5 è visibile la chiesa di S.Giovanni Calibita con il n.1093 e la corsia ospedaliera con il n.1094. Con visione pionieristica e infrequente per l'epoca fu istituito il principio che ogni malato disponesse di un proprio letto e fu effettuata la divisione in reparti distinguendo tra le diverse patologie.
Nel Brogliardo del Catasto Urbano di Roma (fig.B6) (il Catasto fu attivato nel 1824 ed aggiornato fino al 1871) è riportato al progressivo 35 del Rione Ripa l'ospedale come proprietà dei Padri Benfratelli, identificato con i numeri civici 38 dell'Isola di S.Bartolomeo (3 piani) e 60 della Via delle Mole (3 piani nella parte est, senza numero civico, e 2 piani al n.60). Agli stessi Padri, al progressivo 35 ½, è attribuita la proprietà della chiesa di S.Giovanni Calibita con la "Porteria", l'ingresso principale al complesso, al numero civico 39 dell'Isola.
Nel 1865, grazie al lascito di Francesco Amici deceduto nel 1858, fu realizzata dall'architetto Azzurri una moderna corsia riservata agli uomini (fig.B7). L'area dove era situata la Sala Amici è attualmente occupata dalla degenza del 2° piano fronte Trastevere.
Nel 1873, tre anni dopo l’annessione di Roma al Regno d’Italia, venne estesa alla città di Roma la legislazione eversiva che che prevedeva la confisca dei beni immobili degli enti ecclesiastici in base alla quale, nel 1878, l’ospedale e la farmacia dovettero essere consegnati al Municipio di Roma. Nel 1887 la farmacia fu affittata all’associazione civile dei Fatebenefratelli e finalmente nel 1892, grazie anche alle amicizie di cui godeva fra Orsenigo, il dentista dell'ospedale celebre in tutta Roma, i Fatebenefratelli riuscirono a riscattare definitivamente farmacia ed ospedale versando un’ingente somma di denaro.
Nel 1930 i Fatebenefratelli, con un contributo economico del Vaticano, acquistarono tutti i fabbricati sull’estremità ovest dell’isola che, tra molte polemiche, furono demoliti insieme ai locali annessi all’ospedale; nel 1934 fu completata la ricostruzione dell’ospedale sul progetto di Cesare Bazzani che mantenne però la facciata verso la piazza S.Bartolomeo.
Nel 1972 l’ospedale assunse ufficialmente il nome di S.Giovanni Calibita Fatebenefratelli, dal nome della chiesa che ne costituì il nucleo originario ed è tuttora inglobata, e fu classificato come Ospedale Generale di Zona. Perfettamente adeguato ai tempi, oggi l’ospedale dispone di 420 posti letto e nuovi ed attrezzati reparti. La Sala Assunta, oggi trasformata in Aula Magna, ospita importanti convegni e congressi internazionali.
L’ospedale è sempre stato presente nelle vicende di Roma: è stato il punto principale di ricovero in occasione degli scontri del 1849 durante la sfortunata Repubblica Romana, nel 1870 alla presa di Roma da parte dei Piemontesi e durante l’occupazione nazista nel 1944 quando anche molti ebrei vi furono ricoverati e nascosti. Da ultimo nel 1982 vi furono assistiti i feriti dell’attentato alla vicinissima Sinagoga.LA SALA ASSUNTA E LA FARMACIA
La Sala Assunta, costituente parte del nucleo iniziale dell'ospedale, fu ristrutturata e ammodernata probabilmente a partire dal 1680, e sicuramente era già completata quando, il 1° Marzo1702, papa Clemente XI effettuò la sua prima visita. Nel dipinto di fig.C1, in cui è rappresentata la visita di papa Clemente XIII nel 1759, essa appare ben illuminata e dotata di due file di 25 letti individuali a baldacchino e cortine. La sua ampiezza consentiva, all'occorrenza, di aggiungere altri 25 letti mobili nel corridoio intermedio: essi, muniti di ruote, erano comunemente detti "cariole", romanesco per carriole (da cui il popolare insulto in uso tuttora a Roma "...e di tuo nonno in cariola").
L'ingresso principale era da piazza S.Bartolomeo, attraverso il portone dell'attuale farmacia; all'estremità opposta era un altare dedicato alla Madonna, l'Assunta, da cui il nome della sala, per consentire ai malati di seguire le funzioni religiose senza muoversi dai propri letti (fig.C2). Il dipinto dell'Assunta, portata in cielo da due angeli e racchiuso entro una cornice barocca ad angioletti di stucco, è un'opera del primo '700. Il paliotto d'altare (fig.C3), in scagliola policroma, risale al 1681. Nella volta del salone sono raffigurate scene della Vita di San Giovanni di Dio affrescate da G.P.Schor.
In occasione della visita del 1702, raffigurata nel dipinto di fig.C4 attualmente nel refettorio del convento, papa Albani (Clemente XI) concesse ai Fatebenefratelli la piazzetta che era ad ovest della Sala Assunta per l'ampliamento della corsia (dalle memorie di fra Tommaso Mongai: "...e concesse al nostro Spedale la Piazzetta che resta dietro lo Spedale, acciò potesse la Religione stendere la fabbrica del medesimo"). Su tale area fu quindi costruita una seconda sala, il cosiddetto "ospedale nuovo", capace di circa 20 letti, sopraelevata di circa due metri rispetto alla Sala Assunta e ad essa raccordata con le due rampe semicircolari ai lati dell'altare, visibili nel dipinto di fig. C5. Tale ampliamento è riscontrabile confrontando la pianta del Falda (fig.B4 - 1676) in cui è visibile la piazzetta, con quella del Nolli (fig.B5 - 1748) in cui si distinguono le due corsie raccordate dalla doppia rampa di scale. In onore del papa il suo stemma fu riportato sull'arco, tuttora esistente (fig.C3 e C5), che separava le due sale.
Il dipinto in fig.C5, andato perduto a Milano nel 1943 sotto ai bombardamenti, raffigurerebbe la seconda visita di Clemente XI, effettuata nel 1705 per l'inaugurazione della nuova sala; tuttavia recenti studi [10] hanno evidenziato che in tale data la sala non era ancora realizzata e che pertanto il quadro è da ritenersi dipinto prima del suo completamento, probabilmente come ringraziamento alla generosità del pontefice, ciò confermato dalla evidente diversità dell'arco rappresentato da quello poi effettivamente realizzato.La presenza di una farmacia è da ritenersi contemporanea all'insediamento dei Fatebenefratelli nell'isola in quanto la sua esistenza è documentata già alla fine del 1500. Nella relazione della Visita Apostolica del 1663 si legge: "Contigua al portone del convento, dentro una stanza assai capace e rispondente nella strada pubblica, si esercita da un secolare, che ha ivi la comodità di abitarvi, la spetiaria..." e in quella del 1699 che la "farmacia stavicino al portone del convento a mano sinistra nell'entrare, dove vi è la porta". La farmacia occupava quindi il locale tra la Sala Assunta e il corridoio di ingresso del convento, accessibile da una porta che si apriva su quest'ultimo; una seconda entrata verso il chiostro fu fatta murare per maggior custodia della clausura. L'accesso al pubblico sul lato strada avveniva probabilmente solo attraverso una grata, come in uso all'epoca. La fig.C6 raffigura l'interno della farmacia come appariva intorno al 1960.
L'integrità della Sala Assunta, testimoniata dalla pianta del Lanciani ancora all'inizio del 1900, viene interrotta con gli interventi di ristrutturazione dell'ospedale del 1932, allorché la nuova farmacia ne occupò la parte terminale utilizzandone l'ingresso principale sulla piazza S.Bartolomeo; un secondo ingresso fu aperto su piazza Fatebenefratelli.
Il primo dei sei affreschi che decorano il soffitto della Sala Assunta è tuttora visibile sul soppalco della farmacia, utilizzato come deposito dei farmaci.
La corsia rimase attiva per le degenze fino al 1982 quando fu ristrutturata allestendo nella parte ovest l'attuale Sala Convegni da 250 posti (fig.C7), sul cui soffitto sono visibili due dei sei affreschi originari, e destinando la parte rimanente ad uffici.I LAVORI DAL 1930 AD OGGI
Pur non essendo mai venuta meno l'attività di adeguamento dell'ospedale all'evoluzione dei criteri sanitari, nel 1930 si decise di effettuare un considerevole ampliamento e una ristrutturazione radicale, il cui progetto fu affidato all'arch. Cesare Bazzani.
A tale scopo furono acquistati e demoliti tutti i fabbricati sull’estremità ovest dell’isola, visibili nella fig.D1; ciò fu possibile anche grazie anche all'interessamento e a un contributo economico del pontefice, tanto che la licenza fu ottenuta il 2 luglio 1930 dopo appena 14 giorni dalla richiesta.
Le demolizioni, completate il 12 Settembre 1931, interessarono anche parte dei locali dell'ospedale stesso, tanto che solamente un quarto dei circa 180.000 mc costituenti il vecchio complesso fu mantenuto.
Per le nuove fondazioni furono usati circa 800 pali in cemento collegati da travi, murature in tufo e mattoni per i sotterranei; fu inoltre demolito il vecchio campanile sostituito dall'attuale. La situazione comparata prima e dopo la ristrutturazione, inclusi gli ulteriori interventi effettuati fino al 1983, è mostrata nella fig.D2.
All'interno della Sala Verde un'epigrafe in latino (testo integrale) ricorda l'incontro avvenuto l'11 aprile del 1934 in quella che era la Sala Capitolare per celebrare la fine dei lavori di ristrutturazione alla presenza del Card. Marchetti Selvaggiani e dell'arch. Bazzani.
Nel 1957, su progetto dell'arch. Martini, furono edificate la palazzina per la Curia Generalizia e fu modificato l'accesso all'ospedale con la costruzione dell'attuale portineria; la fig.D3 mostra l'ospedale come appariva all'inizio degli anni '60. Nel 1965-66 nella Sala Assunta furono realizzati i box di degenza.
Nel novembre 1977 il Priore generale Pierluigi Marchesi avviò una nuova e radicale ristrutturazione, affidandone il progetto agli architetti Sergio Cobolli Gigli e Giorgio Monico, che elaborarono una proposta per il riordino dell'intero ospedale dal punto di vista sia tecnologico che funzionale.
Il progetto, approvato all'inizio del 1981, prevedeva la costruzione delle centrali tecnologiche allora inesistenti e la ricostruzione di tutti i servizi ospedalieri. Per reperire gli spazi necessari furono realizzati nuovi soppalchi, in particolare tra il secondo e quarto piano, con l'acquisizione di circa 1000 mq, e furono trasferiti all'esterno dell'ospedale gli uffici e le strutture non strettamente legate alle funzioni ospedaliere (il magazzino generale, l'alloggio delle Suore, la Scuola infermieri, l'Ufficio Ragioneria, l'Ufficio del Personale, alcuni ambulatori e la sede della Curia Generalizia).
Nel 1982 la Sala Assunta fu completamente ristrutturata e trasformata nell'attuale Sala Convegni capace di 250 posti.
Oltre ai lavori di miglioramento ambientale condotti tra il 1985 e il 1993, nel 1994 vennero effettuate, sotto il coordinamento del geom. Caporilli, opere di scavo e sottofondazione per l'acquisizione di nuovi spazi e scavi archeologici: gli scavi interessarono inizialmente tutti gli spazi esterni non edificati di proprietà dei Fatebenefratelli, per circa 1200 mq, nei quali sono state costruite le centrali tecnologiche; successivamente si è proceduto allo scavo dei cortili (fig.D4) e dei volumi sottostanti l'ospedale ricavando ulteriori 3000 mq di superficie utile destinati ai servizi ospedalieri. -

L'ospedale Israelitico
GLI EBREI A ROMA
Anche se i segni delle prime presenze del popolo ebraico si fanno risalire al II secolo a.C., l'arrivo in massa degli ebrei a Roma è legato alle deportazioni di decine di migliaia di essi come schiavi ad opera di Tito dopo la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C.
La loro condizione si modificò nel tempo fino a permettere agli ebrei l'organizzazione di comunità libere ed indipendenti, sempre caratterizzate da un senso forte di identità e di distinzione dal resto della popolazione. Tali comunità si attestarono a ridosso del Tevere utilizzando il fiume come fonte primaria di attività economiche e commerciali: le zone principali degli insediamenti furono dapprima Trastevere, intorno a piazza in Piscinula, e successivamente anche sulla riva sinistra, al Portico d'Ottavia dove sarebbe sorto il ghetto, proprio in fronte al Ponte Fabricio, noto per questo anche come Pons Judeorum.
In Trastevere è tuttora presente in vicolo dell'Atleta, nel sotterraneo di un ristorante, quella che si ritiene la più antica sinagoga, risalente al XIII secolo (fig.A1 e A2), da alcuni identificata come quella di Nathan ben Jechiel (1035-1106).IL GHETTO
Fino a tutto il medioevo gli ebrei romani, particolarmente dediti ad attività di commercio, non ebbero particolari difficoltà di convivenza con la popolazione cristiana. Ma durante il Rinascimento, dopo lo scisma protestante, la Chiesa di Roma divenne maggiormente coercitiva nei confronti della popolazione non cristiana tanto che il 14 luglio 1555, appena eletto, papa Paolo IV Carafa (1555-1559) con la bolla “Cum nimis absurdum”, revocò tutti i diritti concessi e ordinò di confinare i circa 3000 membri della comunità ebraica in un'area ristretta, il quartiere conosciuto come ghetto. [testo integrale originale]
Per attenuare tali disposizioni il successore Pio IV (1560-1565) nel 1562 istituì a favore degli ebrei lo “Jus Gazzagà” (diritto di possesso) secondo il quale i cristiani mantenevano la proprietà delle case poste nella zona del ghetto, ma senza il diritto di sfrattare gli ebrei che vi alloggiavano né di aumentarne l'affitto.
Originariamente le porte del Ghetto erano solo due; nel 1577 ne fu aperta una terza. La porta principale era sulla Piazza Giudea (ora scomparsa, dove si trovava, fuori dei confini del recinto, la fontana, unica risorsa di acqua potabile del ghetto), le altre due vicino alle chiese di S.Angelo e di S.Gregorio.
Nel 1589 Sisto V (1585-1590) revocò alcune restrizioni e allargò il ghetto includendo il lungo stabile affacciato sul Tevere e via della Fiumara (ora scomparsa) ai capi della quale furono costruite due nuove porte. Il ghetto raggiunse un'estensione di 3 ettari.
Nella figura B1 sono riportati, sulla pianta del Nolli del 1748, i confini, i nomi e le posizioni delle cinque porte e i nomi delle strade principali del ghetto.
Dopo oltre due secoli l'insostenibile incremento del numero di residenti costrinse Leone XII (1823-1829) a concedere un ulteriore ingrandimento del ghetto: fu così incluso (1825) lo stabile tra via della Reginella e via di S.Ambrogio con l'apertura di un corridoio tra via di Pescheria e via Rua e l'aggiunta di altre tre porte, per un totale di otto (v.fig.B2).
Finalmente il 17 aprile 1848, la sera di Pesach del 5608, Pio IX (1846-1878) ordinò l'apertura delle porte del ghetto e la demolizione delle mura, che fu però completata solo nel 1885. In concomitanza con la costruzione dei nuovi argini del Tevere si procedette all'abbattimento di tutti gli edifici del ghetto ad eccezione dello stabile, tuttora esistente, tra via della Reginella e via di S.Ambrogio.TRADIZIONE SANITARIA E PRIMO OSPEDALE
La comunità israelitica, pur limitata dalle norme antiebraiche vigenti a Roma, prosperò grazie a commercianti e artigiani, amministratori e fiduciari del pontefice, studiosi e medici, questi ultimi soprattutto tra i rabbini.
L'attitudine medica sopperì alle difficili condizioni ambientali del ghetto, mantenendo le condizioni sanitarie ad un livello paragonabile a quello del resto della città. Durante la peste del 1656 il rabbino Zahalon rilevò addirittura che “la pestilenza colpì anche gli ebrei, i quali però guarivano più in fretta dei cristiani”.
Una prima Opera Pia Ebraica nacque nel 1600 con lo scopo di provvedere ad una elementare assistenza sanitaria, prevalentemente domiciliare, alla popolazione israelitica a cui era impedito l'accesso agli ospedali romani.
Nel 1881, per iniziativa popolare di una quarantina di piccoli commercianti che si tassarono per 10 lire ciascuno, si costituì l' “Associazione via della Fiumara 26 per il ricovero degli ammalati poveri”: nella malsana via che costeggiava il Tevere (fig.C1) era quindi sorta una vera e propria casa ospedaliera, anche se costituita da una semplice casa di due stanze con solo quattro letti e gestita da personale volontario, dove però era garantita l'osservanza delle regole religiose anche per la preparazione del vitto.
Al tempo dell'apertura del ghetto, nella comunità ebraica si contavano oltre trenta confraternite di beneficenza e assistenza sociale e sanitaria: da questo nucleo si partì per la creazione della “Deputazione centrale israelitica di carità” (1885), un nuovo organismo di supervisione assistenziale nato dalla fusione e riorganizzazione di alcune confraternite.L'OSPEDALE ISRAELITICO ALL'ISOLA TIBERINA
Alla fine dell’Ottocento, grazie alla generosità di alcuni ebrei benestanti, furono avviate nuove istituzioni assistenziali che ebbero il merito di facilitare l’inserimento dei più poveri nella città, ormai capitale del Regno d’Italia, dopo oltre duecento anni di clausura nel ghetto ormai fatiscente e destinato ad essere demolito.
In tale ambito Angelo Tagliacozzo, uno degli esponenti più in vista della comunità ebraica, riuscì ad ottenere in concessione dal sindaco di Roma Luigi Pianciani l’ala sinistra dell’ex convento Francescano di San Bartolomeo all’Isola, di proprietà comunale. In tale sede fu subito trasferita (1882) l’Associazione di Via della Fiumara, che mutò il nome in “Ospedale israelitico Bet Aholim” (in ebraico “Casa degli infermi”), in cui confluirono le rimanenti confraternite assistenziali e a cui la “Deputazione centrale israelitica di carità” affidò tutte le attività sanitarie relative alla comunità ebraica.
Nello stesso fabbricato fu alloggiato, nel 1887, anche il “Ricovero per israeliti poveri e invalidi”, erede della tradizione di assistenza agli anziani già rappresentata dalla confraternita “Mosclav Zechenim” (Asilo dei vecchi). (fig.D1 e D2)
La distruzione del ghetto, avvenuta in pochi mesi, creò il problema sia economico che sociale del trasferimento in nuovi alloggi: molti ebrei, aiutati dal “Comitato per il decentramento degli Israeliti poveri di Roma”, creato nel 1884, si stabilirono in Trastevere, vicino al vecchio quartiere e al nuovo ospedale che, sempre più attrezzato, divenne un punto di riferimento come istituzione sanitaria.
Nel 1911 l’Ospedale fu riconosciuto come opera pia con lo scopo di: “curare gratuitamente gli ammalati poveri israeliti aventi il domicilio di soccorso in Roma, affetti da malattie acute o croniche non contagiose né diffusive”, e ne fu approvato lo Statuto con Regio Decreto. Il regolamento consentiva di ospitare occasionalmente ebrei non bisognosi, anche se di passaggio da altre città, ma a pagamento e senza inficiare l'assistenza ai poveri. La tradizione dei medici-rabbini, tra cui vanno ricordati il primo medico dell’ospedale Samuele Toscano e il direttore Benedetto Zevi, continuava quindi nel nuovo ospedale.
L’Ospedale disponeva allora di 17 letti più altri 8, separati e collocati in un’ala dell’adiacente convento di S.Bartolomeo, destinati ai malati cronici. (fig.D4)
L’attività dell’Ospedale fu supportata economicamente da un sussidio garantito prima dal Ghemilud Chasadim (Opera di beneficenza) e poi dalla “Deputazione centrale israelitica di carità”, nonché da lasciti di singoli benefattori tra cui merita di essere ricordato per la sua generosità Mosè Levi.L'OSPEDALE OGGI
L’Ospedale israelitico è attualmente integrato nel sistema sanitario della Regione Lazio essendo ormai aperto a tutti i cittadini e organizzato per la cura di ogni patologia. E’ tuttavia particolarmente qualificato per la chirurgia della mano e come struttura geriatria: ciò coerentemente con la sua tradizione di vicinanza alla casa di riposo per anziani, il già citato Ricovero per Israeliti Poveri Invalidi. Nel 1975 l’Ospedale Israelitico ebbe la classificazione di “Ospedale Provinciale Specializzato Geriatrico”.
Nel 1970 la Direzione Sanitaria dell'ospedale, i Reparti di Degenza, il Day Hospital, il Laboratorio Analisi, la Radiologia e gli ambulatori sono stati trasferiti alla Magliana in via Fulda insieme al Ricovero per Israelitici Poveri Invalidi, divenuto poi autonomo nel 2001 e nuovamente trasferito in via Portuense nel 2003. Nei vecchi locali al primo e secondo piano dell’ex Convento di San Bartolomeo all’isola, recentemente restaurati nell’ambito dei lavori per il Giubileo 2000 (fig.E1 e E2), sono rimasti la Direzione Generale ed Amministrativa e un grande poliambulatorio specialistico. Un terzo poliambulatorio è stato aperto nel 2000 in zona Marconi.
L’Ospedale dispone complessivamente di 120 posti letto; 24 sono destinati per day-hospital medico chirurgico con oltre 20.000 accessi annui. Nell’ambito di un progetto assegnato all’ospedale dalla Regione Lazio nel 2000, viene attualmente assicurata assistenza domiciliare di tipo oncologico ed integrato a circa 80 pazienti.
Nella seconda metà degli anni '80 è sorta una controversia, ancora non risolta, con l'Associazione per il Museo Storico dell'Isola Tiberina (AMSIT) che rivendica il diritto ad occupare il Palazzo Pierleoni Caetani all'isola Tiberina inclusi i locali attualmente utilizzati dall'Ospedale.
Questi i riferimenti:
Ospedale Israelitico (sede centrale e ambulatorio): Via Fulda 14 (zona Portuense-Magliana)
Sedi ambulatoriali: Isola Tiberina - Piazza San Bartolomeo all'Isola n.21 e Via Veronese 59 (zona Marconi). -

Oratorio dei Sacconi Rossi
La “Veneranda confraternita dei Devoti di Gesù al Calvario e di Maria Santissima Addolorata in sollievo delle Anime sante del Purgatorio”, detti per il colore dei loro sai “Sacconi Rossi”, fu costituita nel 1760 come sodalizio per la pratica quotidiana della Via Crucis "meditando sulla passione del Redentore" e giovare così "alle anime costrette in Purgatorio".
Nel 1768 fu accolta dalla comunità francescana di San Bartolomeo sull'Isola Tiberina. La confraternita promuoveva preghiere in suffragio dei defunti e si occupava di raccogliere e dare sepoltura ai cadaveri abbandonati, specie a quelli annegati nel Tevere.
Nel 1780 i Sacconi Rossi acquistarono la sala a tre navate posta al piano terra dell'ala sinistra del convento e la trasformarono nel loro oratorio. Similmente alla Cripta dei Cappuccini in via Veneto, anche qui i Sacconi Rossi usarono le ossa dei morti per “decorare” pareti e nicchie della cripta-cimitero, tuttora visibili. Tali pratiche sono state mostrate nel discusso film-documentario “Mondo Cane” del 1962 di Jacopetti (v. https://www.youtube.com/watch?v=uSKAaT84Suk - sequenza dal minuto 52.44 a 55.01).
Pochi anni dopo (1784) Pio VI concesse alla Confraternita di “costruire" un cimitero sotto l’Oratorio, che fu usato fino al 1836 quando Gregorio XVI ne ordinò la tumulazione pubblica presso il Verano. Nel 1849 le truppe francesi del Generale Oudinot saccheggiarono i locali dell'oratorio e della cripta trasformandolo in dormitorio. Dopo una breve ripresa delle attività cimiteriali sotto il pontificato di Pio IX, nel 1871 il regolamento sanitario del Regno d'Italia vietò definitivamente la sepoltura negli ospedali e nei conventi decretando, di fatto, la fine dell'attività della Confraternita che si estinse nel 1960.
Nel 1983 la Venerabile Arciconfraternita di Santa Maria dell’Orto raccolse autonomamente l’eredità dei Sacconi Rossi. Dal 1988 l’Ospedale del Fatebenefratelli e, dal 2023, il Gemelli-Isola, ha la disponibilità dell'Oratorio: per tenere ancora viva la tradizione dei Sacconi Rossi viene celebrata la processione il 2 novembre di ogni anno: la sera, al lume delle torce, gli adepti, con saio e cappuccio rosso, dopo la SS Messa nella chiesa di San Calibita, aprono il corteo che si svolge dalla piazza di San Bartolomeo alla banchina del Tevere. Qui, dopo un'ultima preghiera, viene gettata in acqua una corona floreale in onore dei deceduti del fiume.
Testo di Bruno Leoni
-

La basilica di S.Bartolomeo
LA STORIA
La basilica di "San Bartolomeo all’Isola" fu costruita verso la fine del X secolo (nel 997 secondo Gregorovius) per volontà dell’imperatore germanico Ottone III, in onore dell’amico martire Sant’Adalberto, sulle rovine di un antico tempio romano votivo in onore di Esculapio (si racconta che Ottone scelse l’Isola Tiberina per poter vedere la chiesa dal suo palazzo sull’Aventino).
Ottone III arricchì la basilica da lui fondata di reliquie di santi, tra cui quelle di San Paolino da Nola e dell’apostolo Bartolomeo. Il nome della basilica mutò in breve tempo daAdalberto a Bartolomeo: già nel 1088, su alcuni documenti, viene indicata come S. Bartholomeus a Domo Ioanni Cayetani e in una iscrizione datata 1113, quella inferiore visibile sul portale d’ingresso della basilica, si ricorda soltanto la presenza dei corpi dei santi Bartolomeo e Paolino da Nola. (fig.1)
Durante il pontificato di Pasquale II (1099-1118) la chiesa fu completamente rifondata, come documentato dalla iscrizione superiore sullo stesso portale; a quell'epoca risale probabilmente anche il campanile romanico che affianca la chiesa.
Gli interventi di riedificazione si conclusero nella seconda metà del XII secolo, al tempo di papa Alessandro III (1159-1181), e portarono la chiesa alla configurazione tuttora visibile nelle sue linee essenziali.
Resa titolo cardinalizio nel 1517 da papa Leone X, la chiesa di S. Bartolomeo fu affidata nel 1524 ai francescani dell’Osservanza.
Durante il pontificato di papa Giulio III (1550-1555) la Confraternita dei Molinari si insediò nella cappella a sinistra dell’altare maggiore, e vi rimase fino al 1846.
Nel 1557 una disastrosa inondazione danneggiò in maniera irreparabile la facciata con i suoi mosaici, la navata destra e la zona del presbiterio, distruggendo anche la decorazione pittorica e musiva dell’interno; ne rimane solamente un frammento conservato nella Sala del Mosaico, ex coro dei frati, sopra al portico (fig.2). La chiesa fu quindi temporaneamente abbandonata e le reliquie trasferite nella Basilica Vaticana.
Nel 1583 il cardinale Anton Giulio Santoro patrocinò il restauro della facciata, della navata destra e del presbiterio, la costruzione di un nuovo ciborio in sostituzione di quello medioevale di cui riutilizzò le quattro preziose colonne in porfido, trasferite poi nel 1829 in Vaticano nella Galleria degli Arazzi, e il ritorno delle reliquie dell’apostolo Bartolomeo dalla Basilica Vaticana. Le reliquie furono deposte nell’antica vasca di porfido rosso che ancora oggi è basamento dell’altare maggiore. (fig.3)
Nella cappella dei Molinari furono collocate nel 1601 le reliquie di S. Paolino e dei santi Adalberto, Esuperanzio e Marcello; nel 1636 San Paolino da Nola divenne protettore della Confraternita.
Dal 1608 al 1621 il cardinale Michelangelo Tonti chiamò Antonio Carracci (1589-1616), nipote di Annibale, ad affrescare quattro delle sei cappelle laterali della basilica.
Al tempo del cardinale spagnolo Gabriele Trejo Paniacqua (1621-1630) risale l’esecuzione della nuova facciata, del soffitto ligneo e alcuni altri interventi minori.
Il Cardinal Nepote Francesco Barberini finanziò nel 1638 la costruzione dell’ala del convento francescano alla sinistra della facciata (1639), simmetrica a quella edificata nel XVI secolo e oggi non più esistente, ma visibile in alcune incisioni d’epoca. (fig.4)
Nel 1694 i francescani installarono, nei locali circostanti la basilica, il proprio Collegio Missionario, attivo fino al 1885, anno dell’esproprio statale.
Nei primi decenni del Settecento il cardinale spagnolo Antonio Cienfuegos, titolare dal 1721 al 1739, promosse e finanziò la sistemazione delle balaustre di accesso alle cappelle, il pavimento e la ricca decorazione a stucco che orna l’intera navata centrale della basilica.
Nel Settecento alcune importanti istituzioni religiose si insediarono in S. Bartolomeo tra cui la "Confraternita dei Devoti di Gesù al Calvario e di Maria SS. Addolorata", detta dei Sacconi Rossi per il caratteristico abito usato durante le processioni, fondata nel 1760, i cui membri si incaricavano di raccogliere i cadaveri abbandonati e in particolare quelli degli annegati nel Tevere, seppellendoli in un cimitero sotto all’oratorio.
Nel 1798 la chiesa fu occupata dell’esercito francese; i danni lasciati dall’occupazione militare resero necessario, nel 1801, il restauro dell’area del presbiterio.
Nel 1852 Papa Pio IX (1846-1878) donò alla chiesa un nuovo altare, sistemato intorno alla vasca in porfido con le reliquie dell’apostolo, e commissionò una campagna di lavori negli anni 1865-68, promuovendo una raccolta in danaro allo scopo.
Durante i tragici mesi dal settembre 1943 al giugno 1944 la basilica, come altri conventi e case di religiosi di Roma, dette rifugio a decine di ebrei, nascosti per evitare la deportazione.
Nel 1994 papa Giovanni Paolo II ha affidato alla Comunità di Sant’Egidio la basilica e i locali annessi, e dal 2000 essa è dedicata ai “Nuovi Martiri del Novecento”.LA PIAZZA
Nel 1639, dopo la costruzione dell'ala sinistra del convento francescano, la piazza si presenta comenell'incisione del Falda (1676) (fig.1). L'ala destra era già stata edificata verso la fine del XVI secolo, come sembra testimoniato dalle incisioni del Tempesta (1593) e del Maggi (1625) (fig.2). Alla fine del XIX secolo l'ala destra, così come gli altri edifici dell'isola verso Trastevere, vengono abbattuti per allargare il ramodestro del fiume nell'ambito della costruzione dei muraglioni, e la piazza assume l'aspetto attuale.
Al centro della piazza, dove sorgeva il leggendario obelisco- albero della "nave di pietra", era una colonna su cui venivano affissi ogni anno i nomi di coloro che non si erano comunicati a Pasqua; essa fu sostituita nel 1869 con una guglia (Ignazio Giacometti) come riportato nell'iscrizione: "PIUS IX PONT.MAX IN COLUMNAE LOCUM QUAE PLAUSTRI IMPETU QUASSATA CONCIDERAT PECUNIA SUA FIERI ERIGIQUE IUSSIT - ANNO CHRISTIANO MDCCCLXIX CONCILIO VATICANO INEUNTE [Pio IX Pontefice Massimo, nel luogo della colonna che era caduta a terra rovinata dall'impatto di un carro, comandò che (questa guglia) fosse costruita e innalzata a sue spese. Anno cristiano 1869, inizio del Concilio Vaticano] (v.sezione "Scritte sul marmo").
All'interno delle quattro nicchie sono le statue dei santi: S.Bartolomeo verso la chiesa, poi in senso orario S.Francesco, S.Giovanni di Dio e S.Paolino vescovo. I nomi sono riportati sulla sommità delle nicchie: S.BARTHOLOMAEVS AP[OSTOLUS] - S.FRANCISCVS AS[SISI] - S.IOANNES DE DEO - S.PAVLINVS EP[ISCOPUS] (fig.3).
LA FACCIATA
L'edificio originario era probabilmente più piccolo dell'attuale: l'immagine raffigurata nel disco di pietra nella mano dell'imperatore, in un particolare della vera di pozzo posta ai piedi dell'altare maggiore (fig.4), fa supporre che la chiesa avesse una sola navata.
Nel 1624-25 la facciata viene avanzata incorporando il vecchio portico (visibile nelle incisioni del Tempesta e del Maggi - v. fig.A2) e assumendo l'aspetto attuale, forse su disegni di Martino Longhi, già attivo nella basilica ma deceduto trent'anni prima oppure, secondo altri, per opera dell'architetto Orazio Torriani.
La facciata è a due ordini: l'inferiore è costituito da tre arcate separate da due nicchioni tra colonne di granito, forse destinati ad accogliere statue. La cornice della trabeazione inferiore porta la scritta: "IN HAC BASILICA REQUIESCIT CORPUS S. BARTHOLOMAEI APOSTOLI" [In questa basilica riposa il corpo dell'apostolo S. Bartolomeo] (fig.5)
L'ordine superiore era limitato in origine alla parte corrispondente alle tre finestre centrali e due grandi volute raccordavano il timpano all'ordine inferiore (v. Falda in fig.A1). Nel Settecento furono aggiunte le finestre laterali sormontate dalle piccole volute.
A sinistra della facciata è il campanile romanico (fig.6) a tre ordini di finestre: bifore quelle dell'ordine inferiore e trifore quelle dei due superiori.
Nel corso del recente restauro del portico, che ha portato al rifacimento del pavimento, sono stati rinvenuti resti del portico del XII secolo (fig.7), murati nella parete sinistra, e probabili resti delle trabeazioni di precedenti ingressi.
Il portale marmoreo riporta incise due iscrizioni; (fig.8) quella sul margine interno della trabeazione segnala la presenza nella chiesa dei corpi dei santi Paolino e Bartolomeo:
+QV[A]E DOMUS ISTA GERIT SI PIGNERA NOSCERE QU[A]ERIS.CORPORA PAVLINI SINT CREDAS BARTHOLOM[A]EI [Se desideri conoscere le testimonianze che questa casa contiene, sappi che sono i corpi di Paolino e di Bartolomeo].
Quella sul margine superiore riporta la data di costruzione (1113, al tempo di Pasquale II) e ricorda il trasferimento dei corpi dei santi ad opera di Ottone III:
TERTIVS ISTORVM REX TRANSTVLIT OTTO PIORUM CORPORA - QVIS DOMUS HAEC SIC REDIMITA VIGET - ANNO D[OMI]NIC[AE] INC[ARNATIONIS] MILL[ENO] CXIII IND[ICTIONE] VII M[ENSIS] AP[RI]L[IS] D[IES] IIII T[EM]P[O]RE P[A]SC[A]L[IS] II P[A]P[AE] [Il re Ottone III trasferì i corpi di questi santi - per i quali questa casa così coronata fiorisce - nell'anno dell'incarnazione del Signore 1113, VII indizione, il 4 del mese di Aprile al tempo di papa Pasquale II (l'indizione è un periodo di 15 anni)].
A sinistra e a destra del portale sono murate due lapidi che riportano delibere papali per indulgenze religiose. Sotto la lapide di sinistra è la targa marmorea che indica il livello di piena del Tevere nel 1937; un'altra targa, relativa alla grande piena del 1870, è murata sul lato esterno destro dello stesso portico (v. sezione "Scritte sul marmo").LA NAVATA
Di impianto basilicale, ma con il presbiterio della primitiva basilica fortemente rialzato (v. in fig.1 la pianta del 1744), a tre navate divise da due file di sette colonne di materiali e origini diverse, databili I-II secolo d.C. e forse in parte provenienti dal portico dell'antico tempio di Esculapio (fig.2); le basi sono originali mentre i capitelli in stucco risalgono al restauro settecentesco. Il soffitto a cassettoni è del 1624 ma rinnovato sotto Pio IX nel 1865 (fig.3); le pitture nei tre riquadri maggiori sono opera del frate Bonaventura Loffredo: in quella centrale "S.Bartolomeo rifiuta di adorare gli idoli pagani". Il pavimento cosmatesco originale è andato perduto nei restauri settecenteschi e totalmente rifatto nel secolo XIX.
A sinistra dell'ingresso si riconoscono le strutture residue della base del campanile che fu aperta su due lati, a costituire la parte iniziale della navata sinistra, nel 1625 durante i lavori che portarono all'avanzamento della facciata.
In ogni navata si aprono tre cappelle, nessuna delle quali presenta opere di rilievo: molti dipinti sono stati pesantemente rimaneggiati nel tempo e spesso danneggiati dalle inondazioni del Tevere.
Iniziando dalla navata sinistra si incontrano: la Cappella di S.Antonio da Padova, inizialmente decorata da Antonio Caracci ma rimaneggiata nel secolo XIX; la Cappella della Madonna della Pace, forse la prima opera di un ancora inesperto Antonio Caracci, per conto del Cardinal Tonti, realizzata nel 1609-10; la Cappella della Passione o di Gesù Crocifisso, in pessimo stato di conservazione, anch'essa decorata dal Caracci nel 1610-11.
Nella navata destra, nell'ordine: la Cappella di Santa Francesca Romana, nata e vissuta nei pressi della basilica; la Cappella di S.Carlo Borromeo, ultima opera del Caracci nella basilica (1612-14); la Cappella di S.Francesco d'Assisi, originariamente dedicata a S.Bonaventura.
IL TRANSETTO
Al centro della scala che conduce al presbiterio è collocato l'elemento più singolare della chiesa: la vera di pozzo che costituisce il legame ideale con l'antico tempio di Esculapio. (fig.4) Per la descrizione dettagliata si rimanda alla sezione In particolare.
L'altare maggiore in marmo bianco, dono di Pio IX (v. sezione La Storia), poggia su una vasca in porfido rosso con protome leonina e maniglie in rilievo e un cartiglio con la scritta "CORPUS SANCTI BARTHOLOMAEI APOSTOLI" che testimonia la presenza delle reliquie di S.Bartolomeo (fig.5). Nel pavimento sono inseriti due riquadri del vecchio pavimento cosmatesco. Nella tribuna è raffigurato il "Martirio di S.Bartolomeo" di Francesco Manno (1806) che curò anche la ristrutturazione architettonica dell'abside, mentre il "Cristo in gloria e santi" nel catino absidale e i restanti affreschi sono opera di Bonaventura Loffredo.
Nel lato destro del transetto, preceduta da due leoni stilofori romanici (XII secolo) probabilmente già collocati all'ingresso della vecchia chiesa (fig.6-7) è la cappella della Vergine o del SS. Sacramento, nota anche come cappella Orsini di Pitigliano, famiglia che nel '600 ne assunse il patronato; la posizione della cappella, non in asse con il resto della basilica, farebbe risalire la sua origine al vecchio impianto basilicale. Il soffitto è attribuito a Martino Longhi il Vecchio (1601). Sopra al paliotto d'altare di marmo policromo (fig.8)contenente le reliquie di S.Teodora (vi si legge la scritta "HIC IACET CORPUS BEATÆ THEODORÆ MATRONÆ ROMANÆ"), è un antico affresco (fine '200) scoperto nel 1904 e raffigurante la "Vergine in trono con il Bambino benedicente e santi" (fig.9).
Nella parete sinistra della cappella è incastonata una palla di cannone caduta nella chiesa durante gli scontri del 1849; maggiori informazioni nella sezione In particolare.
Sulla parte destra del transetto, prima di accedere alla cappella, dietro una grata in ferro è custodito un catino di bronzo circolare (secolo X-XI) di fattura araba (fig.10). La tradizione vuole che sia stato il recipiente, o il relativo coperchio, utilizzato per contenere le reliquie di S.Bartolomeo durante il trasporto da Benevento a Roma.
Nel lato sinistro del transetto è l'antica sacrestia che divenne, ad opera di Giulio III (metà 1500), una cappella dedicata dapprima a S.Paolino da Nola, rappresentato "in gloria" (1704) al centro della volta, e attualmente a S.Adalberto. Sull'altare, sormontata da un'Annunciazione seicentesca, è una tela (fig.11) che raffigura "l'Assunta con i santi Paolino, Adalberto, Esuperanzio e Marcello" (1665); le loro reliquie, ad eccezione di quelle di S.Paolino traslate nel 1909 a Nola, sono tuttora conservate nella cappella. La cappella ha costituito fino al 1846 la sede della Confraternita dei Molinari sotto la protezione di S.Paolino ed è decorata con figure attinenti a tale attività visibili nella sezione In particolare. Una lapide sulla parete sinistra ne ricorda un restauro del 1626.
Da una porta sulla parete destra si accede all'attuale sacrestia.
LA CRIPTA
Dal piccolo giardino adiacente al lato sinistro della chiesa si scende alla cripta, in origine accessibile dalla navata della chiesa attraverso due rampe di scale. Nella cripta, crollata durante la piena del 1557 insieme all'abside soprastante e finita di restaurare nel 1975, si può riconoscere l'antica pianta a piccole navate con volte a crociera sostenute da da due file di tre colonnine; due capitelli, originari dell'antica basilica, sono decorati con l'aquila imperiale coronata (fig.12) simbolo di Ottone III. In un piccolo locale si trovano una lapide romana, utilizzata come architrave, e due pietre tombali (fig.13) settecentesche.LA VERA DI POZZO
La posizione della vera di pozzo, attualmente inserita tra i gradini della scala davanti all'altar maggiore (fig.1), potrebbe corrispondere a quella della sorgente taumaturgica dell'antico tempio di Esculapio, rappresentandone il legame ideale. L'ipotesi più accreditata ne fa risalire l'origine alla fondazione della chiesa ottoniana.
Ricavata dal rocchio di un'antica colonna (ne è riconoscibile la base), porta scolpite quattro figure inserite in piccole edicole (fig.2÷5); a partire da quella rivolta verso l'ingresso della chiesa e procedendo in senso antiorario troviamo: Cristo con il libro aperto, un santo (probabilmente Sant'Adalberto) in abiti vescovili con il pastorale ed il libro chiuso, l'imperatore Ottone III recante un disco con il modello dell'antica chiesa e San Bartolomeo con il libro aperto e il coltello del suo martirio.Partendo dalla figura del Cristo, e procedendo sempre in senso antiorario, si riconosce la seguente scritta, inserita in modo irregolare sullo sfondo delle quattro figure:
OS PU-TEI S[AN]C[T]I - CIR CU[N]DANT - ORBE ROTAN TI
[I santi in cerchio circondano la bocca del pozzo]Nella parte superiore della vera sono visibili (fig.6) i segni lasciati dalle corde usate per attingere l'acqua dal pozzo e che ne hanno reso illeggibile la scritta.
LA PALLA DI CANNONE
Nel 1849, durante l'assedio dell'esercito francese alla Repubblica Romana da poco costituitasi (9 febbraio), che portò alla resa dei repubblicani il 4 luglio dello stesso anno, una palla di cannone scagliata dalla Via Aurelia entrò nella chiesa attraverso il muro cadendo, miracolosamente senza provocare danni, sull'altare della cappella della Vergine (quella alla destra dell'altare maggiore).
La palla è stata murata nella parete sinistra della cappella stessa sopra una lapide che ricorda l'avvenimento: il testo è riportato qui di seguito con la traduzione a lato.BELLICUM HOC TORMENTVM
IN PERDVELLES E VIA AVRELIA IACTVM
EXEVNTE IVNIO MDCCCXXXXIX
DISIECTOQVE ANTICO PARIETE HVC IMMISSVM
SOSPITATRICE MARIA OPIFERA
SVPER ALTARE INOPINATO CONSTITIT
FRANCISCALIVM QVE INCOLVMITATEM POSTERIS
REFERTQuesto proiettile di guerra,
lanciato contro i nemici dalla via Aurelia
alla fine di Giugno 1849
e, sfondato il muro anteriore, qui entrato,
per aiuto di Maria salvatrice
si fermò inaspettatamente sull'altare,
e comunica ai posteri l'incolumità dei FrancescaniLA CAPPELLA DEI MOLINARI
Nel locale alla sinistra dell'altare maggiore, inizialmente adibito a sacrestia e successivamente trasformato in cappella da Giulio III a metà del XVI secolo, i mugnai romani stabilirono fino al 1846 la sede religiosa della loro corporazione "Romana Molendinariorum", sotto la protezione di S.Paolino, decorandola con scene della loro attività (fig. 7÷10). Il restauro del sacello contenente le reliquie dei santi custodite nella cappella è ricordato dall'iscrizione sul portale di ingresso alla basilica. A terra sono presenti tracce di un antico pavimento cosmatesco.
La lapide murata nella parete sinistra (fig. 11) riporta, sopra la raffigurazione di un molino, la scritta seguente, relativa ad un restauro del 1626:CAPPELLA DELL'ARTE DE MOLINARI
FONDATA PER DETTA ARTE
ET A BENEFICIO ET COMODO DI QUELLA
DA GABRIELE CRISPIATI
COME CAMERLENGO DI DETTA ARTE
A FONDAMENTI
NEL TEMPO DI GIULIO III FEL MEM
ET L'ANNO MDCXXVI
DA FRANCESCO MORETTI
ET ALFONSO ERCOLANI DEPUTATI
ET CONSOLI DI DETTA ARTE
RESTAURATA A NOME DELL'ARTE
ET PER QUELLAI PERSONAGGI
Ottone III
Sant'Adalberto
San Bartolomeo
OTTONE III
Ottone III nacque nel 980 dall'imperatore sassone Ottone II e dalla principessa bizantina Teopliano (o Teofano), figlia dell'imperatore d'Oriente Romano II. Rimasto orfano del padre a tre anni, l'imperatore-bambino crebbe educato dalla madre, dalla quale apprese l'amore per la cultura, e dai più dotti maestri del tempo. Assunse l'effettivo comando dell'Impero nel 995 appena quindicenne.
Ottone sentiva profondamente come la sovranazionalità del proprio ruolo coincidesse con il recupero della "romanità" del titolo imperiale; considerò quindi tra i suoi aspetti qualificanti del suo regno il rilancio della funzione e dell'immagine dell'Urbe.
Si impose al clero romano perché Brunone di Carinzia, suo cugino, ascendesse al soglio pontificio con il nome di Gregorio V (996-999). L'anno seguente si recò a Roma per ricevere dal nuovo pontefice l'incoronazione imperiale, sul modello di quanto aveva fatto quasi due secoli prima Carlo Magno.
Per realizzare attraverso la fede l'unione delle diverse nazioni europee, Ottone intraprese una serie di pellegrinaggi: in Germania fu raggiunto dalla notizia del martirio di Adalberto (997), a cui era legato da personale amicizia e da sincera venerazione, da parte dei Prussiani che cercava di convertire.
In sua memoria fece erigere una chiesa sull'estremità meridionale dell'Isola Tiberina, dove anticamente sorgeva un tempio dedicato ad Esculapio, dio della medicina (si racconta che Ottone scelse l'Isola Tiberina per poter vedere la chiesa dal suo palazzo sull'Aventino).
Recatosi nel 1000 in solenne pellegrinaggio a Gniezno, in Polonia, per pregare sulla tomba dell'amico martire, ottenne alcune reliquie da portare nella chiesa sull'Isola Tiberina. La chiesa fu arricchita di molte altre reliquie, tra cui la pelle di S.Bartolomeo, il cui nome presto si sostituì a quello di S.Adalberto.
Nel febbraio del 1001 l'incomprensione dei romani sfociò in una nuova rivolta: assediato nei palazzi del Palatino, Ottone abbandonò Roma rifugiandosi nel castello di Paterno alle falde del Soratte in attesa di rinforzi dalla Germania. Ma il 23 Gennaio del 1002, logorato anche da febbri malariche contratte nelle paludi di Ravenna, morì a soli 22 anni.
I suoi fedeli soldati trasportarono il corpo del loro infelice imperatore ad Acquisgrana dove, secondo il suo desiderio, fu sepolto accanto al grande Carlo Magno; del suo sepolcro si è ormai perduta la memoria.
Link di riferimento: "Bollettino di informazioni culturali della Pro Loco di Sant'Oreste (RM)"
SANT'ADALBERTO
Nato intorno al 956 a Libice da una famiglia dell'aristocrazia boema, Vojtech (questo il suo nome originario) venne presto avviato alla carriera ecclesiastica. Compì i suoi studi nella scuola episcopale di Magdeburgo in Sassonia, sotto la direzione di Adalberto, il vescovo che gli aveva conferito la cresima e del quale aveva assunto il nome. Fu ordinato sacerdote a Praga da Thietmar, primo vescovo della città. Membro del clero della cattedrale praghese, Adalberto assunse la guida della diocesi nel 983.
Nel corso dei suoi viaggi in Europa entrò in contatto con importanti ambienti monastici: dopo un soggiorno a Montecassino si era avvicinato a San Ni1o, fondatore del monastero di rito bizantino di Grottaferrata. A Roma aveva trovato ospitalità presso il monastero dei Ss. Bonifacio e Alessio sull'Aventino.
Durante il secondo soggiorno romano (994-996?), il santo ebbe modo di entrare in amicizia con Ottone III, che da allora nutrì per lui grande venerazione.
Adalberto decise di dedicarsi alla conversione delle popolazioni pagane della Polonia. Si recò quindi in terra prussiana, ma la sua missione durò pochi giorni: giunto a Tenkitten per predicare, subì il martirio il 23 aprile del 997. Dopo averlo trafitto con lance e frecce, gli assalitori infierirono sul suo corpo, disperdendone le membra. Il duca Boleslao ne recuperò le spoglie e le fece trasferire a Gniezno, l'antica capitale polacca. Alcune reliquie furono successivamente trasportate nella Basilica di S.Bartolomeo dall'amico imperatore Ottone III. Fu canonizzato nel 999.
La presenza di queste reliquie del santo boemo ha attratto in questo luogo, da secoli, pellegrini di quelle terre. Il culto di Sant'Adalberto è diffuso in Boemia, Italia e Polonia.
Il più antico documento del culto del santo nella basilica di S.Bartolomeo è la vera di pozzo ricavato dal tronco di un'antica colonna di marmo bianco e situato nel cuore della chiesa. In uno dei lati è scolpita la figura di Sant'Adalberto con il pastorale e i paramenti episcopali.
SAN BARTOLOMEO
Bartolomeo era uno dei dodici apostoli; mai citato nelle scritture, si suole identificare con il Nathanael del primo capitolo del vangelo di Giovanni, condotto a Gesù dall'apostolo Filippo e conosciuto con il patronimico Bar-Talmae e cioè Bartolomeo.
Questa pagina evangelica è l'unica fonte certa su Natanaele-Bartolomeo. Nei Vangeli il nome di Bartolomeo compare sempre insieme a quello degli altri discepoli ed anche le sue vicende dopo la morte di Gesù non sono chiare.
Nato a Cana di Galilea, secondo la leggenda diffuse la notizia della morte di Gesù sulla croce. In seguito si hanno sue notizie in tutta l'Asia Minore, dalla Persia all'Armenia, alla Mesopotamia, all'Egitto, dalle coste del Mar Nero, alla Frigia e alla Licaonia (Licaonia era anche uno dei nomi con cui veniva denominata l'isola Tiberina nel Medioevo).
E' tradizione che, dopo l'Ascensione di Cristo, egli abbia predicato il Vangelo in India.
Il "Martirologio romano" di lui scrive: "predicò nell'India il Vangelo di Cristo; recatosi nell'Armenia maggiore, avendo convertito moltissimi alla fede, fu dai barbari scorticato vivo, e, per ordine del re Astiàge, colla decapitazione compì il martirio".
L'antica Chiesa cristiana lo ricorda, insieme a San Taddeo, con il titolo di "Primo illuminatore dell'Armenia".
Le sue reliquie furono trasferite alle Isole Lipari nell'809, di lì a Benevento nel 983 e quindi a Roma.
San Bartolomeo è il protettore di tutti i lavoratori che hanno a che fare con pelli, lame e coltelli come i macellai, ma anche i conciatori, numerosi nel Medioevo proprio sull'Isola Tiberina.
Il giorno di San Bartolomeo, celebrato il 24 di agosto, era festeggiato a Roma con la cocomerata, in cui i ragazzi gareggiavano a nuoto per recuperare i cocomeri gettati nel Tevere.
Le spoglie di S.Bartolomeo [Tratto dall'opera «Reliquie Insigni e "Corpi Santi" a Roma» di Giovanni Sicari ]
Nel 410 le spoglie di Bartolomeo furono trasportate a Martyropolis e Maiafarqin dal vescovo Maruta. Nel 507 vennero traslate dall'imperatore Anastasio I a Darae in Mesopotania. Nel 546 risultano a Lipari e nel 838 a Benevento. Dal 983, portate a Roma da Ottone III, sono nell'antica vasca di porfido dell'altare maggiore della chiesa di S. Bartolomeo Apostolo all'Isola. Sue reliquie risultano sparse in varie chiese europee. Nel 1238 quella della calotta cranica fu portata nella cattedrale di Francoforte sul Meno. Altre sono nella certosa di Colonia e nel monastero di Lune, presso Luneburg. S. Edoardo donò una parte di un braccio alla cattedrale di Canteerbury. Altre ancora risultano in Francia. In Italia la città di Pisa vantava il possesso di parte della sua pelle. La città di Benevento, che ha sempre sostenuto di aver dato ad Ottone III un altro corpo, rivendica il possesso dei suoi resti custoditi nella chiesa a lui dedicata. A Roma, a causa di uno straripamento del Tevere, nel 1557 i resti furono traslati a S. Pietro in Vaticano. Nel 1560 Pio IV li fece riportare con una solenne processione all'Isola Tiberina. A seguito dei danni causati alla chiesa dai francesi nel 1798 alcune sue reliquie furono portate a S. Maria in Trastevere. In questa basilica, nella Domenica in Albis, si mostrava una sua reliquia insigne. Sempre secondo l'Inventario (1870), nel giorno di Pasqua parte della testa era esposta a S. Prassede. Il 1 maggio e il 24 agosto si esponeva (Diario Romano, 1926) parte di un braccio ai Ss. XII Apostoli. -

Il tempio dei Giovani
STORIA E DESCRIZIONE
(Il significato dei termini in corsivo è illustrato nella Legenda)
Il Tempio dei Giovani è una piccola Sinagoga Ortodossa fondata da Sandro Di Castro e Semi Pavoncello e riaperta quale luogo di culto nel dicembre del 1985.
La Sinagoga è ricavata in una grande stanza situata al secondo piano dell'edificio che ospita anche l'Ospedale Israelitico al numero 24 di Piazza S.Bartolomeo all'isola, a pochi passi dal Tempio Maggiore, dal Museo Ebraico e dall'antico ghetto. Il Tempio dei Giovani è situato nello stesso luogo in cui il Rav Panzieri tenne il davening durante il periodo di occupazione tedesca a Roma e la Shoa.
L'edificio fu inizialmente utilizzato come Asilo per i Poveri e i Disabili, ma già da allora un Hazan vi si recava settimanalmente per tenere un Minyan con gli anziani che non potevano recarsi ai templi principali (inizialmente le "Cinque Scole" e successivamente il Tempio Maggiore sulla sponda sinistra del Tevere). Ma nel 1937 il locale divenne ufficialmente un Beit-haKneset e fu arredato con un Teva, un Aron e delle panche collocate nella stessa posizione che occupano attualmente.
Negli anni 1938-39 furono promulgate le leggi razziali ed iniziò la discriminazione degli Ebrei in Italia; tuttavia ciò non arrestò l'attività della comunità e della vita religiosa nel piccolo tempio.
Il Rosh haShana and il Yom Kippur continuarono ad essere celebrati fino al 1943 quando Roma fu occupata dall'esercito Tedesco. L'Hazanche allora suonava la shofar, Giacomo Funaro, fu deportato ad Aushwitz con gli altri Ebrei razziati nel ghetto il 16 Ottobre durante il Sukkot, mentre l'Hazan Amadio Fatucci fu ucciso alle Fosse Ardeatine cinque mesi dopo.
Sebbene gli Ebrei rimasti a Roma fossero costretti a vivere nella clandestinità, la vita del tempio, ormai l'unico Beit-haKneset rimasto a Roma, continuò sotto la direzione del Rav David Panzieri. Era ancora attivo la mattina del 5 Giugno 1944 quando i militari americani della 5a Armata entrarono in Roma e i soldati di fede ebraica parteciparono alla benedizione del haGomel per essere sopravvissuti agli scontri armati di quel terribile anno.
Nel 1970 l'Asilo per i Poveri e i Disabili fu sostituito dall'Ospedale Israelitico e il Beit-haKneset fu ristrutturato: vi fu collocato l'antico Arondella ultracentenaria Scola mentre donazioni private arricchirono il tempio di nuovi seforim ed ornamenti di argento.
L'attuale denominazione "Tempio dei Giovani" fu attribuita da un gruppo di giovani che per qualche tempo vi celebrarono il davening senza la guida di Rabbis o Hazanim. Grazie a loro l'antico minhag italiano con il tipico canto romano si mantenne come preziosa tradizione ed insegnamento per le future generazioni.
Negli anni '90 del secolo scorso il Tempio fu arricchito con finestre a vetri colorati e una mechitza di bronzo, opere su disegno di Aldo di Castro.
Il Tempio dei Giovani è divenuto un accogliente luogo per la celebrazione di Bar/Bat Mitzwah e Matrimoni, e ogni Shabbat vi viene offerto un gustoso Kiddush ai membri e ai visitatori di ogni parte del mondo.